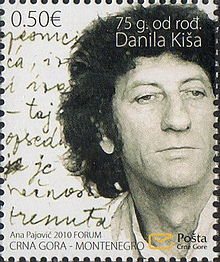Bello? fa lei. Sì, bello, faccio io, e poi ho incontrato delle donne non so, è la prima cosa che mi è venuta in mente, prima dei monasteri dipinti e delle rocche sassoni e delle cicogne e dei villaggi di campagna come i nostri cinquant’anni fa. Ah le romene, dice lei, quelle sì che sono donne. Sì, davvero, dico, simpatiche e pratiche. Belle facce, dico, ho avuto come la sensazione che siano loro, a mandare avanti la baracca. Relazioni umane e intraprendenza. Lei annuisce. Mi racconta di una donna romena, giovane, che ha conosciuto per caso, per strada, o al mercato di Porta Palazzo, non so. L’ha vista buttata là, senza niente, neanche gli occhi per piangere. Si sono parlate, le donne fanno così, a volte, mica stanno là a vedere per cosa e per come. Cora si è incuriosita, è stata smossa da qualcosa, forse l’espressione, dice, o forse, non sa bene dire cosa. Era venuta da sola lasciando là il marito e un figlio piccolo alla nonna, come fanno tante, per cominciare loro a preparare il terreno per la famiglia. Arrivano qua, da sole, al più in tasca l’indirizzo di un connazionale – qua sono quasi tutti di Bakau – che magari poi non mantiene la promessa, della solidarietà nazionale se ne frega. Vieni a fare qualche ora da me in gelateria, le dice Cora, ti insegno, poi vediamo. Così è andata, è stata un po’ di mesi, ha lavorato bene, ha trovato un lavoro migliore e poi un altro. Ha messo su casa, ha chiamato marito e figlio. Adesso viene in gelateria a trovare Cora e a mangiarsi un sorbetto al gelso. Ah le romene, quelle sì che sono donne. Anch’io ho avuto un incontro così, dico a Cora. Mi è venuto in mente durante il viaggio, mano a mano che si allungava la collana dei volti di donna operosa e intraprendente, incontrando Maria di Sibiu, o Silvia, la moglie del pope, e la sua casa per le vacanze a Gura Humorului, oppure Sophia e il suo motel da camionisti che starebbe benissimo nei quadri di un novello Hopper romeno. Oppure Rodica, che esce dalla stalla e ti imbastisce una strategia di marketing impacchettandoti, nel suo salotto buono, nei costumi della festa ricamati da lei, facendoti giocare e aspettando poi il tuo acquisto. O delle due donne – madre e figlia – che a Sibiel dipingono le icone di vetro, colorate e pagane, e ti accolgono con un bicchiere di grappa e un dolcetto, non importa a quale ora del giorno. O Elisa, che gira con George e con la sua bella voce per feste e matrimoni.
Stavo facendo una ricerca sul rapporto tra scuola italiana e genitori immigrati, si dice “genitori” ma poi vedi sempre solo le mamme, e una mamma romena si è presentata come rappresentante di classe. Ho detto, sinceramente contenta, bene!, questa è una bella notizia. Sì, fa lei dura, ma c’è poco da ridere. Che donne toste, queste romene, penso. Lei ha una bellezza irregolare, spigolosa, intensa, occhi verdi che mandano piccoli lampi. Così racconta. Arriva qui dalla provincia di Bakau, sola, marito e due figli al paese. Adesso, dopo il viaggio, me la immagino come quelle giovani donne arrampicate sui carretti che incontri ad ogni passo, trainati dai cavalli robusti, che ti fanno rallentare sulle strade ogni dieci metri o che i romeni sorpassano pericolosamente a fil di rasoio tra un camion e l’altro. Oppure ai bordi delle strade lungo cui si snodano i villaggi senza profondità, di una sola dimensione, tutti affacciati lungo la via con dietro subito la campagna di granturco e patate, e tra le case e la strada una sottile striscia di erba, spesso curata e fiorita, a volte un piccolo rivo, e un marciapiede, dove si svolge la vita: i vecchi seduti sulle sedie che guardano e aspettano la sera, le donne che vendono cipolle o patate o piccoli peperoni gialli, i bambini che scorazzano con le biciclette. Oppure la immagino come quella ragazza in attesa alla fermata del bus affacciata quasi sul niente, in Moldavia, sotto un traliccio incappucciato dal grande nido di due cicogne appollaiate contro il blu del cielo. Adesso mi pare di capire meglio.
Il solito indirizzo in tasca, nemmeno un letto per una notte. Gira, qualche suora, qualche dormitorio, lavori saltuari pagati da rapina. Perde l’ultimo lavoretto, non ha una lira. Smette di comunicare con i suoi, non sa cosa dire, di là le aspettative sono molte. Un giorno peggio degli altri si sente arrivata al capolinea, piove, non ha un ombrello, le scarpe sono sfasciate, non mangia da due giorni. Una donna ben vestita (“una signora” dice lei) le si avvicina, le chiede se si sente bene e se ha bisogno di qualcosa. Lei ha bisogno di tutto perché non ha niente, ma risponde non mi serve niente, solo un lavoro. La donna è la moglie di un imprenditore, la invita a casa, le offre un lavoro come domestica. Poi un altro lavoro, un altro e un altro. Le donne che le danno lavoro le insegnano l’italiano. Affitta un appartamentino in periferia da un’amica della sua nuova datrice di lavoro, e così continua la solita storia. Sì, ma la rappresentante di classe? Dico, come ci si arriva? Mi sono proposta, dice, e mi hanno votato, non solo gli stranieri, anche gli italiani. Quella italiana che era prima di me e non è stata votata ha cominciato a farmi la guerra. Io le ho chiesto: insegnami, come si fa? E lei mi ha detto: se non lo sai fare, dimettiti. Ma io di qua non mi muovo nemmeno se mi ammazzano. Nemmeno se mi ammazzano, mi dimetto. Che donne, queste romene.
Elisa, che suona con George, suo marito e nostra guida, ai matrimoni con bella voce da canto popolare e sonorità un po’ slava e un po’ mediterranea, dice in buon italiano: a me piacciono gli italiani, siete meglio di noi, noi siamo volgari e adesso pensiamo solo a far soldi. Vorrei dirle che il denaro e il mercato sono anche da noi gli dei dominanti, poeti santi e navigatori sono in declino, e che inglesi e tedeschi ci dicono di tutto, dandoci la palma dei più cafoni del mondo. Ma capisco cosa vuol dire. La percezione di un paese in cui si corre verso una ricchezza possibile e disordinata, è netta. Nulla di nuovo, fa parte di ciò che sappiamo e che immaginiamo su quel tappo che è saltato, nei paesi dell’est compressi dai regimi del socialismo reale, e che con una velocità impressionante hanno sbandato in tutte le diverse direzioni del capitalismo rapace, deregolato. Un mix di creatività, arrembaggio, intelligenza operosa, fretta, imprenditorialità, miseria, rischio e sogno. Si respira nell’aria che c’è chi corre e chi è al palo, che le garanzie sociali sono evanescenti, che tutto è in movimento, e che, insieme alle sorti magnifiche e progressive dello sviluppo, qualcosa già rischia di degradarsi per sempre. Le città e le campagne sono universi ancora separati, le città hanno gioielli medievali e barocchi nei centri storici, risanati dove sono arrivati i fondi europei, patrimoni culturali ben tenuti e localini trendy, e brutte periferie – tra eredità del regime e moderno arrembaggio; e le campagne hanno villaggi a nastro sulla strada sconnessa con case curate e fiorite, carri con i cavalli, scenari verdi ancora intatti, un equilibrio che aspetta di sapere cosa gli capiterà. Anche se non c’è nella bibliografia di Eugenio, perché in effetti non c’entra nulla, a me viene in mente di accostare a Magris e Rumiz che leggiamo durante il viaggio, anche Gianni Celati, la bassa padana verso il delta del Po, fatta di struggenti pioppeti e capannoni del miracolo nord est, di antichi tratturi bordati di sambuco e cascine seicentesche, e centri commerciali grandi come città, di osterie dove non una sedia è stata spostata dai primi del novecento e mc donalds ai bordi dei raccordi anulari. In un moto di tenerezza per questo paese che sto appena ora intuendo, mi viene da pronunciare una preghiera, laica e muta, perché un qualche dio degli uomini metta una mano sulla testa a queste terre e non ne faccia un deserto post-tutto. Il Danubio – che in questo viaggio non abbiamo incontrato, riservandoci un sogno – con la velocità della crisi balcanica ha sorpassato il Po, inghiottendo i veleni della guerra, gareggiando in inquinamento mortale con Eridano, e portando a spasso quella storia sinistra di fine secolo verso un Delta già sfregiato. Ma, come dicono Magris e Celati, questi fiumi-patriarchi resistono a tutto, e non cedono la loro poesia, sia che si carichino dei residui della pianura industriale, sia che finiscano in un niente dopo un corso poderoso.
Comunque, ha ragione Elisa, a preoccuparsi. Servono uomini e donne e progetti che sappiano sognare sì, ma anche valutare il rischio.
Le regioni che percorriamo e conosciamo sono Transilvania e Bucovina, che fa parte della Moldavia. Attraversiamo anche un tratto di Valacchia, da Bucarest al nostro arrivo, e, verso la fine del viaggio, un lungo tratto della Moldavia del sud. Gli scenari sono dissonanti: là, dolcezza di boschi, colline e monti, torrenti puliti e armonia di villaggi e monasteri dipinti, equilibri mantenuti, anche se sospesi come quando si trattiene il fiato, tra paesaggio intatto e modernità accumulata in fretta; qui, in Moldavia meridionale, a perdita d’occhio una pianura gialla di stoppie del grano mietuto, si pensa all’Ucraina, o alla Puzta ungherese, al fascino sottile di un nulla aperto sull’orizzonte, cittadine dove qualche equilibrio si è già perduto, forse più povertà. Non una povertà statistica, magari i numeri direbbero il contrario; ma è che nei paesi rurali che possono contare su un bosco di querce e faggi secolari, su un balcone fiorito di gerani, su un orto lussureggiante, su una stalla e su una mandria, su mirtilli grossi come olive e funghi come se piovesse, su formaggi dal profumo intenso, su un bar dove vanno tutti, su case con le porte mai sbarrate, insomma, è come se i conti tornassero meglio.
In Transilvania e Bucovina la natura è dolce e produttiva insieme, selvaggia e domestica, ancora magia dell’equilibrio. I villaggi rurali, disseminati ovunque ma con una densità che lascia al bosco lunghi tratti di silenzio e scarsa presenza umana, hanno quella produttività in armonia con l’ambiente che era anche nostra, negli anni ’50. Buttando l’occhio, dentro la stalla delle mucche di Rodica e Dimitru, a Gura Humorului, e nel loro salotto buono, mi è tornato alla mente il profumo delle Dolomiti, quando a sei anni avevo il compito di andare a prendere il latte con una gamella di alluminio con il manico a mezzo arco, in una casa antica dove una mucca, una sola, manteneva tutto il paese e anche i villeggianti. Lì è così, e anche i carri tornano carichi di fieno, tirati da cavalli pazienti. Sul piccolo monte di fieno ondeggiano paurosamente donne e bambini. Lungo le strade, sul ciglio polveroso, ragazze e vecchi posano secchi di plastica pieni di mirtilli e di porcini, a volte anche di nocciole. Alle spalle, a seconda dell’altitudine, boschi cedui tondeggianti e ombrelli a forma di nuvole verdi, oppure, più in alto, aguzzi e svettanti di pini alti come torri. I cieli sono come quelli del Tiziano, con nuvole ampie e vaporose messe con arte in contrasto con lo sfondo blu.
Le strade sono a buche e sconnessioni. Il pulmino di George ha buone sospensioni, e poi lui sa sempre per tempo quando frenare con decisione. Le strade sono piene di TIR, ti fai l’idea che nel paese circolino come impazzite milioni di merci diverse, che vadano di qua e di là come in un flipper gigante, ballonzolando sull’asfalto butterato. Da Curtea de Arges, prima tappa, ancora in Valacchia, a Sibiu-la-bella, pezzo di Germania medievale e rinascimentale catapultata qui dalle migrazioni dei sassoni, dopo una visita al piccolo monastero di Cozia, prima avanguardia di una serie di luoghi poetici e mistici, ci fermiamo a mangiare on the road. In senso proprio: una trattoria da camionisti – varrà il detto italiano, dove ci sono camionisti si mangia bene? – affacciata su un fiume biondo di terra e dalle sponde verdissime, il tavolo a mezzo metro dalla strada dove si incrociano a velocità sostenuta TIR di tutti i colori, provenienze e carichi. La casa è un po’ finita e un po’ no, nell’angolo casse della mitica birra Ciuc, il nome ci fa ridere, la colonna sonora dei nastri romeni e zingari di George ancora nelle orecchie. Parliamo tra uno spiedino e l’altro – sì, anche qui vale il detto- e tra un TIR e l’altro. Bene, mi dico con una allegria nel cuore, siamo dentro “Gatto nero e gatto bianco”, siamo arrivati a destinazione. Resta un breve video, girato con il cellulare, una manciata di secondi con noi, il tavolo, la birra Ciuc, lo spiedino e dietro un gran via vai di camion dai colori sgargianti.
Mi pare di essere in Germania, mi pare di essere a casa, dice Cinzia, che parla e insegna tedesco e la Germania la conosce bene.. Sibiu-la-bella, e le terre attorno disseminate di chiese sassoni fortificate, hanno architetture mitteleuropee. Così incontriamo il primo dei tanti popoli che hanno attraversato questa terra lasciando segni duraturi. E sono tanti: ungheresi, secleri, rom, tedeschi, turchi, e romeni ovviamentemolte città hanno tre nomi, romeno, ungherese e tedesco. Non sono solo le città, anche i paesi sono così, le case rurali mutano da regione a regione, un museo vivente dei passaggi, delle conquiste, delle idee diverse dell’abitare e fare città. Bifore bizantine e gotico tedesco, barocco e fortezze medievali, modernismo sovietico e rococò alla francese, fino a quel mix di orientale e barocco che va sotto il nome di stile brancoveanu.
Lungo il tragitto verso Sibiu incontriamo un museo etnografico all’aperto: sarà l’unico che visiteremo, o quasi, perché è festa nazionale e non è pienamente in funzione. Su questo apro una polemica senza fine, con il gruppo e con me stessa, perché la Romania ha un museo etnografico ad ogni villaggio, fino al grande museo del contadino di Bucarest, e io se vedo una stanza con dentro un rastrello sdentato e una brocca sbrecciata mi ci fiondo passione sbeffeggiata dai più e anche dalle mie amiche. Minoranza. Non faccio adepti. Incasso la sconfitta.
Segno tutto sul mio libretto delle cose incompiute: “fare il giro dei musei etnografici della Romania”, annotazione per il futuro prossimo Questo, è un villaggio nel verde, dove sono ricostruite tutte le architetture rurali delle diverse regioni, le case di legno e di paglia, le stalle, i pozzi a bilanciere, le filande, i mulini, le cappelle. Fin nel più piccolo particolare di questa architettura minore e contadina emerge l’incrocio dei popoli e delle culture e si rinnova la magia della differenza, quel miscuglio di ragioni – fatto di caratteri, economia, natura, incroci meticci, fantasie e sentire profondo – che fa sì che a pochi chilometri un tetto sia di paglia e un altro di tegole di legno, un mulino abbia vele di tela grezza e un altro di legno scuro. La magia della differenza disegnata dal tempo.
Sibiu è viva, piena di giovani, un primo giro serale ce la mostra quasi viennese, nella piazze e nei palazzi, e tedesca nelle torri, e piena di caffè affollati. Ci sono i tetti con gli occhi, piccoli abbaini su tetti spioventi che pare abbiamo palpebre discrete e guardino di sottecchi. Sui comignoli, grandi nidi di cicogne. Ci sono musei, ma alla fine preferiamo un giro in città, strade e piazze, un borgo del seicento, e un caffè discreto sotto il nido di cicogne. Dormiamo da Maria, la prima di queste donne imprenditrici del nuovo tempo, che vorrebbe chiacchierare ma noi fuggiamo via, la sua casa ai margini del centro storico, da fuori non la indovini, solo un portone in una strada di passaggio, dentro stanze su tanti dislivelli, e un piccolo giardino con un gazebo per la colazione del mattino. A fianco, un orto, e una casa diroccata, prato incolto di periferia, da cui spuntano i primi indizi di un ponteggio. Sibiu-la-bella si fa il maquillage.
La terra sassone ha piccoli villaggi rurali, con le strade sterrate, le case basse, alberi carichi di frutti e orti fioriti, i vecchi davanti alle case, al tramonto, il tempo lento, che solo una incursione curiosa della Lonley Planet strappa all’oblio turistico. Ma niente paura, non c’è folla. A Sibiel c’è una chiesa con un piccolo cimitero, potrebbe essere Tirolo, salvo che lì le croci sono in ferro battuto e qui in pietra, ma si respira lo stesso tramonto viola, con le rondini che volano basse e un campanile con la campana, che al vespro suona con voce calda, tirata su e giù da una ragazza che si intravede appesa alla corda saltare a ritmo, i capelli biondi che svolazzano a tempo. Vicino alla chiesa c’è un piccolo museo, il Zosim Panacea, sono le icone di vetro salvate e collezionate da un prete ortodosso e dalla gente di qui, raccolte nei villaggi, nelle case. Sono icone della madonna, e di san giorgio e di una folla di altri santi e angeli, e poi di un cristo paffuto che dà vita alla vite, il ramo della pianta gli esce dal costato e si sviluppa in grappoli gonfi e coloratissimi. Le icone sono vivaci, pagane e poetiche, Chagall forse ha fatto un viaggio qui, perché ci sono buoi e cavalli che volano nel cielo violetto insieme ai santi e agli angeli. E la madonna mostra il seno, e lo porge, nudo, al bambinello. Sulle pareti delle scale, ritratti fotografici color seppia degli uomini importanti del paese, volti dell’ottocento e del novecento, lo sguardo dritto in macchina, serio, la postura impettita eppure poetica: il pope, il sindaco, il maestro.
Qui, le icone si dipingono ancora. Andiamo a trovare una madre e una figlia nella loro casa bassa. Nel piccolo cortile, una coppia prende il fresco della sera: sono israeliani, e vengono sempre in vacanza qui. Le traiettorie degli uomini sono sempre sorprendenti. Dal cortile, due stanze col tetto basso, il laboratorio. Icone di vetro colorate, le foto della madre e della figlia che dipingono, colori, la confusione di ogni atelier. Decido subito, come quando sono gli oggetti a chiamarti: adamo ed eva, l’albero delle mele rosse, un serpentone d’oro avvoltolato su tronco, in cima il dio con la barba nel triangolo e sotto, sulle radici, una madonna col manto rosso che dovrà darsi un gran da fare, nei millenni successivi, a sconfiggere il peccato. Che poi è anche la conoscenza (come la mettiamo?). Loro, l’uomo e la donna sono deliziosi, lei è decisa, è ben quella che osa i seni a pera, il gonnellino di foglie e la mela, ancora nella bocca del serpente tentatore, ma già saldamente nella sua mano. Lui, si tocca con aria interrogativa la barba, si vede che non sa bene cosa fare, incerto e poco incline a osare. Già si sa, come va a finire. Ecco due altre donne, la giovane e la vecchia, sospese tra passato e presente, tra la strada sterrata, il cavallo e il turismo, tra i campi e la Lonley Planet, tra la tradizione e il business. Ma c’è, ancora, qui, quell’equilibrio, il dio col triangolo non ha tolto ancora le sue mani dal villaggio. Le donne ci offrono un bicchiere di grappa e delle frittelle dolci ancora calde. La grappa prima di pranzo e cena e come benvenuto, non importa quale ora sia del giorno o della notte. Dovremo farcene una ragione.
A Sibiel si cena e poi George finalmente tirerà fuori la sua fisarmonica e le due donne inglesi del tavolo accanto dovranno subire le nostre stonature fino al crescendo epico e invitabile di bella ciao, la sola canzone di cui tutti sanno tutte le parole e non si deve fare, a un certo punto, la la la A loro compenso, la bellezza dei pezzi popolari suonati da George. Questo posto si chiama Mioritica, è di Sorian, un omone con i baffi che mette insieme tutte le lingue, guascone che parla a voce alta e scherza, facendo di se stesso un personaggio. Un maschio imprenditore, finalmente. Il luogo è un insieme di luoghi, una casa centrale, tante casette e stanze di legno disseminate tra fiori esuberanti e disordinati, piccoli giardini un po’ selvaggi, un torrente che scorre tra la casa e un piccolo gazebo arrampicato sull’altra sponda. C’è vento e fa buio, cediamo al desiderio di tepore e ceniamo all’interno, in una sala-museo affastellata di arnesi contadini vecchi e nuovi, di pentole di rame, di rastrelli, di macchine per fare il burro (gioisco, una trattoria-museo). In tavola arriva la mitica polenta romena con il formaggio, la mamaliga, e poi lo spezzatino. E il vino. Mangiamo e cantiamo, la stanchezza è in agguato ma stemperata da una dolcezza fatta di calore, di curiosità, di vacanza, di suoni, di nostalgia non si sa bene di cosa. Prima della cena, il baffo ci mostra anche una stanza minuscola, con un letto di legno, qualche scaffale, una piccola finestra: la stanza del passato. Foto e scritti di Ceausescu, la falce e il martello. “Nostalgico?” gli chiediamo, onestamente incuriositi e pensando anche “e perché no? Qualcuno ci sarà pure..” Lui ride più con gli occhi che con la bocca, fa un gesto come a dire “ma vi sembro il tipo?” Ma il fatto è, dice, che non si deve dimenticare il passato. Giusto, baffo, giusto. La smemoratezza crea mostri.
George voleva che pernottassimo qui, avrei fatto a pugni per una notte nella stanzetta del passato, affacciata sulla falce e il martello. Ma la Lonley Planet ha colpito e non c’è posto.
Da Sibiu-la-bella a Sighisoara il paesaggio è dolce, disseminato di paesi rurali definiti dal “lindore sassone”, Cinzia è sempre più a casa sua, e un po’ anch’io, c’è aria di Tirolo, o di Carinzia, architetture a tetti spioventi, fiori sui balconi, operosità contadina, cieli tersi. Restano sparute terrazze con qualche filare di vite, coltivazione pare portata dai sassoni, sviluppata per lungo tempo ma poi quasi abbandonata. Chissà perché, si dice che questa vite facesse buon vino, e non a caso esce ancora oggi dal costato di cristo carica di grappoli, ma oggi trovare una collina di filari è davvero un terno all’otto. I sassoni hanno lasciato anche tracce meno labili, le architetture di pietra delle chiese fortificate, il divino in guerra, la religione che si erge in difensiva dallo spettro dell’orda turca. La chiesa di Biertan ha un grande fascino, minaccioso e autorevole, si erge sopra un paese contadino ordinato in cui vien voglia di sostare, solo si avesse il tempo, per condividerne almeno per qualche giorno il ritmo (nuova annotazione nel libretto delle cose incompiute), alte e doppie mura di cinta, tetti aguzzi di mattone, la chiesa, le torri, su uno sfondo di colline di querce e faggi. Una torre è detta dei divorzi, pare che le coppie sull’orlo della crisi vi venissero chiuse per qualche settimana con la dotazione di un giaciglio matrimoniale e un coltello, e si stava a vedere come sarebbe andata a finire. Pare che i divorzi effettivi fossero pochi. C’è anche un bel ristorante, ma noi ci fermiamo all’aperto, sotto le mura, dove si vende birra e alcuni vecchi sonnecchiano nel caldo pomeridiano davanti a un boccale della mitica Ciuc.
Sfidando la temperatura del pulmino di George, inesorabilmente rimasto al sole, dotati di un carico di bottigliette di acqua gelata, percorriamo in su è giù il verde altalenante della Transilvania fino a Sighisoara. La città ha anche un nome tedesco e uno ungherese, i sassoni ci sono dal dodicesimo secolo e pare che oggi siano tornati in forze, questa volta non con corporazioni e commerci ma con capitali da investire anche per la rigenerazione urbanistica della città, che alterna stradine sterrate e fangose, quando piove, a palazzetti lindi dalle tinte pastello. Sighisoara è la città natale di Vlad Tepes – il Dracula quello vero, l’eroe che tenne a bada l’orda dei turchi, non il personaggio pedofilo e sanguinario della letteratura – ma nel complesso non si viene aggrediti dal mito turistico e dall’invadenza retorica dei souvenir, fatta salva qualche tazzina con un dracula dentato cui per altro anche noi soccombiamo. Ognuno ha a casa un nipote o un amico che se la aspetta. La casa natale sfugge al mito grazie a un prosaico ristorante che vi si è insediato, lasciando sul muro esterno una lapide sobria, sormontata da un geranio rosso fuoco. La città è bella, tedesca e vivace, più tedesca di così non si può: la torre dell’orologio, che guarda sulle colline morbide su cui sorge la città, esibisce un orologio che ad ogni ora mette in azione un grande carillon, si alternano figure e personaggi, che escono dal buio degli ingranaggi verso la luce della piccola piazza. Più tedesca di così non si può: il perimetro è costellato da torri solide, ognuna porta il nome della corporazione che l’ha costruita e che si prendeva cura della difesa di una porzione della città e del suo muro di cinta, ci sono gli orafi e i sarti, gli artigiani dei metalli e quelli del legno. Una lunga scalinata di legno coperta e ombreggiata da una volta porta al cimitero, sassone anch’esso, dove antichissime lapidi di pietra grigia portano stemmi, simboli, piante stilizzate e animali, smangiati e limati dal tempo e messi lì, con una sorta di disordine casuale e struggente. Piove a tratti, nel pomeriggio, le stradine del centro si trasformano rapidamente in rigagnoli, i nostri sandali lasciano i piedi nudi e ci consentono un refrigerio inaspettato. Ci prendiamo del tempo, ci fermiamo un paio d’ore nella piazzetta centrale, chiusa tra palazzetti colorati, ai lunghi tavoli di una birreria. E’ qui che nascono chiacchierate, racconti di sé, Maria Grazia, Renato, Alessandro, si comincia ad attribuire ad ogni volto del gruppo anche una manciata di parole, brandelli di una storia individuale. L’aria profuma di pioggia e di terra.
La sera ci offre qualche risata, in un ristorante pizzeria dove Gabriella decide di correre l’avventura di una ciorba, una zuppa di trippa. Esperimento non del tutto riuscito. Forse anche perché è agosto ed è stato un giorno caldo, o forse perché lei, ardita, decide di proseguire con un semifreddo gigantesco. Ma ciorba a parte, i tavoli si affacciano sulla città e le sue colline, la serata è dolce, il locale è pieno di giovani e ci aspetta un piccolo hotel barocco affacciato sulla torre, con camere ampie dove dormiremo il sonno dei giusti, e balconi pieni di gerani rossi.
Da Sighisoara, la meta è raggiungere prima di sera Gura Humorului. È un tratto lungo, che porta dalla Transilvania alla Bucovina meridionale, in Moldavia, regione divisa tra Romania e Ucraina dalle mutevoli e ballerine linee tirate sulla carta del mondo dalle guerre e dagli sconvolgimenti della politica del secolo breve. L’attesa è molta, sappiamo di villaggi rurali intatti e di monasteri dipinti, di un fiume che scorre lento sul fondovalle e di boschi a perdita d’occhio. La stanchezza del viaggio è attutita da molte tappe su scenari mutevoli e cangianti.
Inaspettato, sulla strada, un interludio psichedelico. La miniera di salgemma di Praid, non più in funzione, oggi luogo terapeutico: dicono che a star dentro qualche ora alle sue grotte dalle volte altissime e dalle pareti luccicanti, i polmoni ne abbiano giovamento. Non c’è traccia dei mitici minatori romeni, il blocco proletario che non voleva perdere il regime, se non nell’abbigliamento di un giovane con la lampadina sulla testa che vende blocchi di cristalli purissimi a cinque euro. Nella miniera si entra con un bus doppio affollato di una umanità che potrebbe star bene anche a Rimini, che imbocca a tutta velocità un tunnel buio in discesa, con le pareti lucide che sfiorano le fiancate e i finestrini. Ti aspetti qualcosa di simile a qualcosa che hai già visto: Postumia, la Grotta del Gigante nelle Marche, oppure quella del Carso triestino, o qualche miniera in disuso, nelle valli trentine o piemontesi, con quel fascino un po’ sinistro e un po’ nostalgico delle opere umane in disuso, quel buio, quel silenzio. Giù dal bus e una lunga teoria di scalini di legno in discesa, verso il ventre della terra. Alcune grotte si aprono una dopo l’altra, sono altissime, sono vastissime, hanno un pavimento levigato e lucido, pareti a tratti luccicanti. Ma non c’è silenzio né struggente nostalgia del proletariato d’altri tempi. E’ una città, una città affollata di abitanti, migliaia di persone. C’è la grotta-disneyland, con i giochi colorati di gomma gonfiata, scivoli, castelli, tappeti elastici. Ci sono schermi televisivi lcd inchiodati alle pareti di sale che proiettano partite di calcio sulle teste di centinaia di persone-protei seduti su lunghe panche da bocciofila. Ci sono lunghe teorie di tavolini addossate alle pareti con coppie di ogni età e sesso che giocano a dama e a scacchi. C’è un bar costruito in legno stile Texas. C’è una chiesa con altare, panche e statue di sale dei santi e della madonna, e un calendario con gli orari delle messe. C’è uno struscio (un liston, si dice in veneto) di centinaia di persone che passeggiano, si incontrano, si salutano, chiacchierano, e bambini e genitori che giocano nel bel mezzo delle grotte a volano, a palla, a tennis. In certi tratti, devi farti largo.
Restiamo per un attimo allibiti. Una sensazione come di straniamento, da mondo parallelo. Come per un fungo amazzonico o un’agave psicotropa. George sembra tranquillo, noi siamo stupiti, divertiti, spiazzati e insieme incapaci di riprenderci. Potrebbe essere un mondo post-catastrofe, penso. Un mondo dopo l’apocalisse in cui – al contrario di quanto avviene in molti romanzi – l’uomo non si fa lupo, ma riorganizza una vita solidale. Una eccezione romena al pessimismo globale sul “dopo”, una lezione a Mc Carthy, quello de La strada. Lo meriterebbe, la minieria, un romanzo post-catastrofico.
Miniera di Praid, Romania, anno 2008, l’incipit:
Il giorno non arrivava. L’esplosione aveva oscurato l’orizzonte, il sole restava chiuso nella sua nuova notte perenne. George sentiva il freddo penetrargli nelle ossa, aveva dato la sua giacca a Elisa, quando l’aveva vista così, accucciata contro il muro di pietra, tremante. Traiano non tornava, aveva voluto andare oltre il fiume, a cercare del cibo, chissà, una patata rimasta nel campo, un peperone giallo salvato nell’orto, o magari, con un colpo di fortuna, una gallina sperduta. Improvvisamente, lo vede, arriva di corsa, agita le braccia, ansimando. Ha una borsa di stoffa a tracolla, la esibisce con orgoglio e risata da guascone: “Mele, mais, salame e formaggio di capraeh, che dici?” “Ma dove “ balbetta George, che da più di un mese non incontra un essere umano diverso da sua moglie e dal suo amico, “Dove?” “Andiamo – dice Traiano – sveglia Elisa. Andiamo alla miniera di Praid. C’è gente lì, si sono organizzati”. “Ma chi dice che ci faranno entrare, magari” “Andiamo, ti dico c’è Livio, il sassofonista di Brashov, è un amico”. George scuote con dolcezza Elisa, lei si sveglia con un piccolo sussulto, come un animaletto inseguito che non può permettersi di sognare.
Boschi a non finire, Transilvania-la-verde corre verso il suo confine, prima della Moldavia, il Lago Rosso e le gole di Bicaz. Boschi di conifere, un lago non diverso dai nostri laghi alpini, non fosse per quei tronchi impiantati sul fondo, che affiorano come una selva rovesciata. C’è molta gente, la poesia del luogo si perde, lo immagino in ottobre, col silenzio e i colori dell’autunno. Se la poesia si perde, rimangono però i mici, polpettine grigliate e profumate: fuochi e graticole a perdita d’occhio in stand affollati, buon profumo di carne, birre, ora non so più se ancora Ciuc o già Ursus, non amo la birra e non ho imparato la sua geografia romena. Così ci concediamo una festa popolare sulle rive del lago. I mici sono piccanti, l’aria tersa, con la coda dell’occhio vediamo la strada che comincia a salire.
Le gole di Bicaz sono un valico montuoso con le pareti a strapiombo sulla strada, che si incunea e sale. Le gole si aprono su uno scenario di boschi a perdita d’occhio, costellati dell’offerta ai bordi della strada di mirtilli, funghi, nocciole, che via via si fa sempre più aperto, sino a diventare collina e poi campagna, piana e intensamente coltivata. Sulla strada, l’avamposto dei monasteri che riempiranno le prossime ore, Agapia. E’ quasi un villaggio, perché fuori dalle mura del monastero si assiepano piccole case di legno bianco, immerse in giardini fioriti, divise da stradine di terra bianca dove passeggiano padroni galli e galline. Le monache ortodosse, chiuse nei lunghi abiti neri dai cappellini a tamburello coperti a loro volta dal velo, abitano anche le casette di legno, via via acquisite dai contadini. Il monastero ha una chiesa centrale, silenziosa e dorata, dove si celebrano riti per me misteriosi e inquietanti, con le suore che hanno una gestualità continua, ripetitiva e individualista, il pope che appare e scompare, un altare nascosto, la ritualità del velo che si apre e che si chiude, e una intimità esclusiva e celata del prete con dio, fedeli che si inchinano con movenze islamiche, teche e scrigni che espongono alla sguardo e alla preghiera reliquie che non identifichiamo, e donne vecchissime, con un secolo addosso, che si confessano con un pope che sembra ancor più vecchio di loro, il volto solcato da mille rughe e una strana fissità, e si confessano senza alcuna protezione, così, addossati su un lato della chiesa. I muri sono affrescati di blu, di oro e di rosso, l’atmosfera è intima, raccolta, magica. Il monastero, bianco di calce, è fatto di una serie di alloggi, con terrazzini e balconate fiorite, senza soluzione di continuità tutt’attorno alla chiesa e al cortile, come una corona. Le suore hanno una tessitura che è famosa in tutta la Romania: grandi telai verticali, sopra, appese, le matasse di lana colorata, grezza, che ad annusarla sa di pecora, e mi ricorda quella che fino agli anni ’60 si trovava in Cadore, in una piccola filanda sotto casa mia, costruita a ridosso del torrente dove, fino a subito dopo la guerra, girava la ruota di legno di un mulino. Questo viaggio, a tratti, mi catapulta indietro nel tempo, nella mia infanzia, quando i nostri villaggi di montagna erano intatti come questi villaggi romeni. Con l’odore della stalla, con le strade sterrate dei paesi, con la lana ruvida al tatto, e odorosa. Sui telai, le spole, ora ferme, domani mattina riprenderanno a correre a destra e a sinistra, disegnando uccelli, e fiori e geometrie fantastiche.
Siamo stanchi, adesso, e abbiamo voglia di arrivare. C’è ancora strada, colline basse, pianura, campi dove il grano ha lasciato il posto alle stoppie secche, il granturco è già cresciuto, e si alterna ai girasoli. I villaggi si dipanano lungo la strada, le cicogne fanno i nidi sui pali della luce. A tratti, qualche mostro industriale giace ai bordi della campagna, tetro e fuori mercato, accartocciato in attesa di chissà quale destino. Il fiume Moldova scorre lento, costeggiato dalla ferrovia che taglia le strade con poco preavviso, ma George lo sa, spinge sui freni, attraversiamo i binari saltellando e guardando a destra e a sinistra, non si mai. Non dev’essere un gran che, la rete ferroviaria: su mille attraversamenti dei binari, solo due volte è capitato di vedere un treno. Di nuovo colline e un orizzonte verde, Gura Humorului, la porta dei monasteri dipinti. Lasciamo il centro abitato, seguiamo il fiume verso la casa dove ci aspetta Silvia, la moglie del pope. Incontriamo tanti carretti tirati da cavalli grandi e pazienti, carichi di fieno e di donne e bambini, e intanto il cielo si fa violetto. Non si può dire che Ceausescu abbia lavorato per la meccanizzazione dell’agricoltura come Lenin aveva fatto per l’elettrificazione della Russia, almeno non a prima vista.
La casa in cui Silvia – eccola, un’altra donna che vive il suo tempo presente! – ci accoglie è moderna e spaziosa, con un giardino, un albero da frutto davanti alla porta, una grande cucina, tante stanze che si affacciano su un ballatoio interno. Si lasciano le scarpe fuori e ci sono pantofole di panno per tutti. Silvia ride e parla forte, è allegra e materna. Noi siamo stanchi, ma la sua cena è un balsamo, una cena che finisce con una crema dolce e un liquore di mirtilli fatto in casa che va giù che è una bellezza (anche troppo). Per la sera seguente promette anche di più, e l’incontro con il marito, il pope del paese a cui alcuni di noi vogliono chiedere qualcosa sulla chiesa ortodossa. Non abbiamo sonno, però: due passi lungo la strada fino al bar del paese e alla chiesa, nel buio che a tratti è denso e solo qua e là tagliato da un lampione. Sui lati, case basse, giardini, fiori, silenzio, qualche cane che abbaia, dal bar poche voci maschili dietro la siepe discutono come in tutti i bar di paese del mondo. Un cane comincia a seguire Eugenio, si fa accarezzare e non lo molla fino a casa di Silvia. Entra in giardino e non ha alcuna intenzione di andarsene.
I monasteri dipinti di Humor, Voronet e Moldovita meritano la loro fama, sono bellissimi e unici. Le pitture sulle pareti esterne hanno colori intensi, che connotano ogni monastero con tonalità diverse, qui domina il blu, lì il verde, là il rosso. E’ come se Giotto e la sua scuola fossero passati di qui, e stanchi del chiuso della cappella degli Scrovegni, avessero portato i loro pennelli e i loro ponteggi all’aperto e alla luce. I monasteri sono circondati da giardini fioriti, con pozzi coperti da un tetto di legno e chiusi da mura con una porta di legno intarsiato. Le pitture hanno temi ricorrenti, san Giorgio e il drago, la madonna, il giudizio universale, con i salvati tra gli angeli e i dannati che varcano il fiume rosso dell’inferno inseguiti e tormentati da orribili diavoli. Tra le folle dei dannati, ricorrono turchi, ebrei, armeni, i “nemici”, ognuno con i suoi costumi, e copricapi e tratti del volto. E’ un mondo in guerra, un mondo minacciato e che minaccia. I monasteri, del resto, risalgono proprio all’epoca della minaccia turca, e avevano una funzione sociale, rassicurante e pedagogica. I quadri rappresentati sulle pareti erano come un grande libro che tutti potevano leggere e capire, scritto per sancire una identità e per dare speranza, per compattare contro l’aggressione. A interrompere il rischio della ripetitività – che un po’ è come in Toscana con le madonne del trecento, stupende ma alla centesima rischi di non “vederle” più – a Moldovita arriva suor Tatiana, altro volto femminile da non scordare. Mezza età, piglio deciso, occhi verdi sempre mobili, una bacchetta in mano e un approccio da insegnante di liceo in mezzo a un branco di studenti smidollati, nel suo buon italiano imparato stando con i turisti, Tatiana ci guida in modo autoritario sì, ma anche naturalmente autorevole e colto, tra un intreccio mirabile di significati nascosti e metafore che legano un quadro dell’affresco all’altro, una storia parallela di simbolismi complessi, mistici e segreti, legati dalla figura della madonna, un femminile – dalla “mandorla” che include il cristo alla caverna – che restituisce speranza a quel mondo di guerra e di minaccia, di peccato e di peccatori. Tatiana ci dice come un testo, che qualcuno potrebbe leggere come un gran fumettone di qualche secolo fa, nasconda teologia, mito, misticismo, storia, filosofia e pietas per il destino umano. “La finestra si sporca”, dice indicando con un segno circolare il suo busto, dal cuore allo stomaco e al fegato, e agitando la bacchetta da maestra spiega che il peccato entra in noi quando ci affacciamo al mondo, ma noi stessi abbiamo la facoltà di ripulirla. Tradotto nel mio linguaggio ateo: possiamo presidiare noi stessi, la nostra integrità. Abbiamo la possibilità di farlo. Così, tranquillizzata, ringrazio Tatiana anche per questo.
Tra un misticismo e l’altro, c’ è anche una pausa pranzo deliziosa, tra un monastero e l’altro. Una locanda che si chiama Halta Lu Lului, si presenta come una piccola stazione ferroviaria, c’è anche un treno in miniatura, ha tavoli ombreggiati, un grande prato davanti e una terribile sala all’interno piena di animali imbalsamati, che evitiamo con cura. Qui, nonostante siano trenta gradi e passa, facciamo la conoscenza della tochitura moldoveneasca, sponsorizzata con passione da George, polenta, formaggio piccante di capra, un mix di carne di maiale e salsicce e – come se proprio non bastasse – un uovo fritto. Meravigliosa e letale.
Tornando a Gura Humorului, ci aspetta una serata intensa. Vorrei dire, quasi mondana. Primo, l’incontro con Rodica e Dimitru. Lui, un vecchio contadino dall’aria nobile e le mani nodose, bacia la mano a noi signore con un lieve inchino, in segno di rispetto. E’ silenzioso e sorride. Lei, massiccia e pratica – ah, un’altra donna del nuovo millennio che sa cavalcare l’onda con occhio al futuro – cura la stalla, fa i formaggi e organizza il suo bed&breakfast. La loro casa è ai margini del paese, ha una piccola stalla, un fienile, camere in affitto e un salotto “buono” dove Rodica “sequestra” noi donne per un rito che un po’ ci fa ridere e un po’ ci imbarazza. Veste due di noi (anch’io sono tra le prescelte) con gli abiti della festa, una gonna nera fermata in vita da una fascia colorata e una camicetta scollata e a sbuffo. Ridiamo e ci facciamo fotografare dalle due “scampate”, forse dovremmo comprare qualcosa ma davvero sarebbe dura utilizzare quegli abiti nelle nostre giornate metropolitane. Rodica non insiste, il gioco finisce. In compenso assaggio il suo formaggio, con tutti i sapori dell’erba e del fieno, e con gli altri partiamo per un breve tour con Dimitru, il suo cavallo e il suo carretto. Dopo una breve analisi della situazione, il contadino-nobile saggiamente aggiunge un secondo cavallo: siamo in tanti e nemmeno molto esili. Per le stradine del villaggio, chi torna dalla campagna e sul carretto ci sta ogni santo giorno, perché nessuno qui ha meccanizzato niente, ci saluta ridendo, e forse pensando che siamo un po’ scemi. Ma non importa, noi stiamo bene, il tramonto è viola e almeno una volta, durante questo viaggio, la stupidera del turista ci compete.
A cena da Silvia – peperoni imbottiti, quelli di qui, che sono gialli e piccoli e profumati – c’è anche il pope, in borghese, e alcuni vicini di casa, due donne e un ragazzo, Livio. Così si chiacchiera, affaticando George che deve tradurre tutto, ma può contare sull’aiuto di Livio, che fa su e giù con Pavia, un migrante pendolare e interinale. Livio parla bene italiano, è ingegnere alimentare e a Pavia fa lavori di vario genere, certo non il suo. Ma, dice, fare il mio mestiere qui mi farebbe guadagnare 500 euro al mese, là guadagno di più. Così, su e giù come un matto in macchina attraverso i Balcani, cinque o sei volte l’anno, tutta una tirata. Le due donne – una è sua madre – fanno le farmaciste veterinarie, hanno occhi verdi luminosi e i capelli freschi di parrucchiere.
Quando George tira fuori la fisarmonica, si tirano da parte le sedie, loro ballano e cantano, noi siamo un po’ più timidi. C’è aria di paese e di semplicità. Silvia scherza a voce alta, parole in italiano, parolacce, le solite che sanno tutti gli stranieri, e se la ride sonoramente, un divertimento da bambina. Il pope, suo marito, la guarda tra il divertito e il perplesso: dev’essere un gioco delle parti che nella coppia di lunga data va avanti da decenni. Anche il pope, a serata inoltrata, si scioglie. Racconta barzellette, se da noi si dice “ci sono un italiano un francese e un inglese” lì, a casa di Silvia, si esordisce con “ci sono un rabbino, un prete cattolico e un pope ortodosso”, e giù a ridere. Si discute anche di differenze tra i riti cattolico e ortodosso, si capisce che le differenze di tipo teologico non sono molte, qualcuno dice “però voi potete sposarvi, è una buona cosa”, ma il pope fa cenni con le mani, non è detto, dice, che sia una buona cosa, lui la moglie se la deve tenere una vita, mentre una perpetua la si può licenziare. E se la ride di cuore, con Silvia che fa a gara per ridere più forte. E anche noi, grazie al liquore di mirtillo, il cui livello, nella bottiglia di cristallo, è sceso paurosamente. La mattina seguente, il pope passa a salutarci, ha il vestito da prete, e sembra un altro, con una certa aura di autorevolezza, si pensa che, così, non potrebbe mai dire c’erano un rabbino, un. Silvia sta per piangere, dice che vorrebbe che Eugenio fosse suo figlio, lo vorrebbe adottare e tenere con sé.
La giornata di viaggio dalla Bucovina verso Ivesti, una traversata della Moldavia, è faticosa, un lungo viaggio di trasferimento, interrotto da uno sguardo lanciato sulla città di Iasi. Faccio carte false per una visita al museo etnografico (finalmente!) ma sbatto contro un giorno di chiusura. Intravediamo una città gradevole, una chiesa gotica, proviamo una sosta nel parco della città, ma troviamo transenne e gru e il cartellone che illustra un progetto avveniristico per un centro cultural-convegnistico alla Renzo Piano, che si appoggerà al grande palazzo neogotico della Cultura.
Niente Iasi. Si riparte, per approdare a un altro momento on the road, un pic nic con sottofondo di TIR nel luogo più metafisico del viaggio. E’ una piazzola verde per soste e spuntini, che si apre su un bosco fitto, è costellata di rifiuti a mucchi, ha un tavolo con le panchine e due statue di pietra che guardano il nastro d’asfalto e danno le spalle al bosco. Così, come una scenografia un po’ metafisica. Una porta un mazzo di spighe e un falcetto, a mo’ di mietitrice sovietica da piano quinquennale, l’altra, più morbida, un cesto di grappoli d’uva. Stanno lì, ascoltano il rombo dei TIR, presidiano le bottiglie di plastica buttate sul prato, guardano verso sud. Noi discutiamo se sia più efficace, contro quelli che sporcano i prati, la pedagogia della repressione o quella del lento convincimento educativo, non siamo d’accordo e litighiamo un po’, ma con scarsa veemenza. Intanto, Gabriella trova un fazzoletto di erba senza rumenta e si mette a leggere sotto le mietitrice. Mangiamo i panini che ci siamo fatti a casa di Silvia con tutto quel ben di dio che c’era per colazione.
Scendendo attraversiamo una Moldavia via via sempre più piana, fino a perdere i suoi confini in un infinito giallo-stoppie di grano, cavalli sparsi nei campi come una manciata gettata a caso nel vento. Di tanto in tanto, i villaggi a nastro sulla strada. C’è aspettativa, per Ivesti, il villaggio dei rom.
Da noi impazza il delirio securitario, impronte, campi rasi al suolo, razzismo a piene mani, il bel paese sembra aver trovato il suo “nemico perfetto” su cui concentrare il nostro moderno malessere. A bordo si leggono pagine sulla loro storia, della lontana terra di provenienza, l’India, e della schiavitù fin in tempi recenti, venduti come animali, corpi senz’anima messi al lavoro. Io sono reduce da un viaggio a Sofia, in Bulgaria, dove loro sono tanti, una minoranza “vera” , eppure stanno chiusi in quartieri ghetto dai condomini cadenti, i cortili incolti e sporchi, una vita sociale dura e degradata, tradizioni immobili che cortocircuitano con la modernità post-tutto e la cultura dell’arrembaggio del post comunismo. Però almeno il regime aveva fatto dei condomini per loro, avevano detto i miei compagni, mica come da noi. E i capifamiglia lavoravano tutti nelle fabbriche. Certo, le più schifose, le prime ad essere chiuse con l’arrivo del mercato, e adesso nessuno più lavora. Una specie di modello inglese alla buona, aveva detto qualcuno: non vi integrate, non vi chiediamo niente, statevene nei vostri quartieri, a patto che rispettiate le regole. Sì, però dopo l’89 tutto è scattato indietro come una molla, il pregiudizio e i conflitti secolari hanno radici profonde, le fabbriche dello stato e i condomini di cartongesso, no. Ero andata a visitare un drop-in per consumatori di eroina, per imparare, anche da noi adesso ci sono giovani rom che si fanno. Ho trovato due stanzette in uno dei condomini a pezzi, però colorate e ben tenute, e quattro operatori pagati un cazzo su questa barricata sociale, che davano siringhe pulite, offrivano (inutilmente) preservativi, facevano medicazioni e colloqui con ragazzini poco più che bimbi. Sarebbe utile il metadone, dicono. Ma perché, non c’è? dicono i nostri occhi allibiti. Sì, ci sarebbe, ma adesso se lo devono comprare loro, non lo passano più gratuitamente. Ce lo vediamo un ragazzino dipendente di sedici anni con due soldi in mano che deve decidere tra la roba e il farmaco. Il giorno dopo mi son trovata con uno sparuto gruppo di consumatori organizzati a fare una colletta pubblica per l’acquisto del metadone. Gioie della privatizzazione.
E allora, dopo Torino e Milano e Roma e la Bulgaria, sono molto curiosa di vedere come se la passano i rom romeni. Mi son fatta un’idea di tolleranza e di un villaggio di case di legno colorate che vive con dignità, magari col cavallo legato fuori. Ne abbiamo visti molti di rom sui carri, nella campagna.
Perciò poi lo spiazzamento è davvero grande.
Loro, a Ivesti, hanno una strada né bella né brutta, un po’ fuori dal paese, lungo la quale si snodano le case. Le case sono fantastiche, sono palazzi a volte enormi, tutti intarsiati e decorati di cose luccicanti, con dei tetti di metallo a pagoda, un po’ orientali un po’ indiani, con punte aguzze, pinnacoli, piccoli campanili svettanti. Alcune sono palazzi forse da decine e decine di stanze. Siamo frastornati: ben ci sta, così impariamo ad avere aspettative truccate da quello che abbiamo creduto di sapere, di loro. Loro, sono proprio loro: i vestiti delle donne, gli atteggiamenti degli uomini, i bambini dagli occhi sfrontati e intelligenti, sono sempre gli stessi, in ogni angolo del mondo. Qui curano la loro via con grande dispendio di scope e secchi e ramazze, perché sul marciapiede non vi sia nemmeno un granello fuori posto. Le donne stanno sedute sulla via, sulle panchine, sotto i tettucci che coprono gli ingressi delle loro case favolose. Ne visitiamo una, George lo chiede a un giovane uomo che sta sulla porta, non è la sua casa, è quella del figlio di dieci anni che si è sposato con una ragazzina di dodici. Stomaco chiuso: rispettare sì, accettare no, soprattutto le culture patriarcali, su cui non mi concedo buonismi. Lei è piccola e tenera, bella, ed anche orgogliosa della sua casa. Ne avrai di strada da fare, bambina, penso. Gli sposi piccoli hanno una casa grande, marmi e saloni, e un bagno grande come casa mia. Sul soffitto, lampadari e abbellimenti a forma di dollaro e di euro, colorati di colori acidi, verde, arancio, fucsia. I soldi, come “la roba” del Verga, dei nostri vecchi contadini. La roba, come un secolo fa. L’oro, come illusione di una ricchezza che si può “toccare”, una sicurezza e un vanto, a confronto con l’impalpabile evanescenza virtuale delle azioni e delle borse. Renato e Maria Grazia avevano delle caramelle, pensavamo ai bimbi rom assiepati attorno ai noi, quando si dice le aspettative sbagliate. Qualche caramella va comunque, i bambini sono bambini. Facciamo una foto con un gruppo di donne e intanto ci accorgiamo che qualcuno di loro sta fotografando noi. Stupendo, ben ci sta.
Nel gruppo serpeggia disagio, anche contrarietà: ma come, noi che ci preoccupiamo tanto e invece e la fonte di tanta ricchezza? Quali circuiti di uno stato in smantellamento saranno stati intercettati? Con quale legalità? Vederne alcuni “ricchi” stona, non tornano i conti. Ognuno risponde allo spiazzamento a modo suo. A me viene da ridere per una strana allegria, mi fa allegria mettere queste case fantastiche di fronte al campo di strada dell’Arrivore a Torino, al suo fango, al suo schifo. Mi fa allegria questo ostentare la rivincita sugli schiavisti, sul mondo. Certo un po’ all’inglese: state qui e non vi mischiate. Però in una reggia da fiaba. E mi fa allegria anche pensare a certi dibattiti: loro stanno meglio nei campi, figurati, in un alloggio normale starebbero malissimo, non è la loro cultura. Eccole, le case che a loro piacciono, se solo possono.
Ecco un vero viaggio, che è tale solo se spiazza almeno un po’, se non conferma proprio tutto ciò che già sapevamo.
Proseguiamo per Brashov, dove arriveremo la mattina seguente. La notte si passa on the road, al motel di Sophia, eccola un’altra donna che sa quello che vuole, vissuta in Italia, si è portata l’uomo qui e ha messo su questa impresa, a Hanu Monachi, luogo di cui vediamo solo un gran via vai di carretti dalla campagna e un bel po’ di TIR. Motel, ristorante, bar, serate per i giovani con birra e musica. Fa anche matrimoni, da me vengono anche i rom, dice, sono l’unica che li prende, metto a tavola anche cinquecento persone. Non ne dubito, con quegli occhi e quel modo di fare, anche di più. Mentre il tramonto diventa viola e dal balcone della camera un novello Hopper romeno dipinge la sua strada grigia, i suoi camion e il suo solitario camionista che fuma una sigaretta appoggiato a un palo della luce, giunge dal bagno l’urlo di Gabriella, che si è chiusa dentro e la porta difettosa la imprigiona. Agitazione poi la vigorosa spallata di Cinzia la libera (dovremo dirlo a Sophia, si rischia di stare in quel di Hanu Monachi per giorni) In bagno c’è anche un tombino, dove defluisce l’acqua del lavandino e della doccia, nulla di che, ma non è coperto e c’è qualcosa di inquietante che gorgoglia sul fondo. Immaginiamo un condotto dal tombino di Sophia alla miniera di Praid, qualcosa che ci inghiotte e ci scaraventa nell’antro post-catastrofe dove ciò che resta dell’umanità ha trovato rifugio. E’ uno di quei momenti in cui si torna al liceo, quando nessuna cosa al mondo riuscirebbe a bloccare un riso incontrollato e senza senso. A noi tre pace stare in camera insieme proprio per questo.
Hanu Monachi è anche il luogo dove incontriamo Elisa e Traiano, sì, proprio, un nome impegnativo per un uomo vivace che ride volentieri e che suona e canta con George. Elisa è la moglie di George, bella, feeling immediato, bella voce, repertorio italiano e romeno della tradizione popolare, suonano per noi e per un gruppo rumoroso di ragazzi del posto che trinca birra con ritmo impressionante. Ci sono quasi solo maschi, qui, da Sophia, ma dove stanno tutte queste donne che tengono su il paese? Noi non siamo all’altezza, siamo stanche e non ci lanciamo, ma ascoltiamo con piacere la serata in nostro onore. A una canzone romena seguono sguardi ridenti e ammiccanti dei ragazzi, Alessandro si preoccupa, chissà che cosa dice, ‚Äòsta canzone e loro? ah, dice poi Elisa, a me non piace, è una canzone pornografica. La serata finisce in una stanchezza morbida, lo spegnersi di un giorno lungo.
Verso Brashov, tornano i boschi, un orizzonte dolce. Però abbiamo poco tempo, solo uno sguardo alla piazza di nuovo tedesca, seduti a un tavolo davanti a torta e birra, poi un giro attorno alla “chiesa nera”, e la scritta sulla collina come quella di Hollywood. Questa è la città di Stalin, e un tempo la collina era tosata a dovere per far risaltare il suo nome all’orizzonte. Ora la strada è in salita, serpeggia tra boschi e villaggi, è montagna, pini e verde intenso. Puntiamo al castello di Bran, detto di Dracula anche se lui, quello vero, Vlad Tepes, ci è passato di straforo. Il castello è bello, il suo profilo si staglia imponente contro un cielo annuvolato, purtroppo è stato molto rimaneggiato, nei primi del novecento, perdendo un po’ della sua cupa bellezza, addolcendola. Una guida ci accompagna, ci tengono molto anche qui a parlar bene di Vlad, insomma, questo Stoker ha fatto uno sgarbo ai romeni creando il suo personaggio sanguinario, e sembrano tutti un po’ offesi. Del resto, sarebbe come se qualcuno avesse fatto di Lorenzo de Medici un serial killer di bambini. Non sarebbe piaciuto nemmeno a noi. Pur comprendendo questo punto di vista, restiamo perplessi quando ci viene spiegato che era in realtà un nobile che governava con polso, comminando pene severe, anche impalare il reo, ma allora si sarebbe potuto tranquillamente lasciare fuori una borsa piena di soldi, provate a farlo adesso beh, proporre di ripristinare il palo ci è sembrato un po’ forte, lo sarebbe anche nell’attuale dibattito italiano, che è tutto dire. Con tutto rispetto per Vlad, eroe della lotta ai turchi.
La casa di Maria, che ci accoglie per la cena, è un’accogliente abitazione di montagna, con i letti a castello, la mitica polenta con lo spezzatino, una serata piovigginosa che ci fa mettere maglioni e k-way. Una cena intima come in un rifugio, Maria è una giovane donna accogliente, ha una figlia bella e ben difesa da un padre deciso a arginare sul nascere gli sguardi dei nostri giovani compagni di viaggio. Si parla del gruppo di polacchi che si son persi in montagna e non tornano. Poi prima della buonanotte, col buio, i polacchi arrivano un po’ stravolti, bagnati e nemmeno salutano.
Colazione presto, le marmellate di Maria fatte in casa, la tisana di menta e limone, il salame, il formaggio. Piove, ma sta schiarendo. Ancora boschi, poi sfumano verso la piana di Bucarest. La città non la visitiamo, non c’è tempo prima del volo e forse c’è poco da vedere. Attraversiamo periferie fatte di condomini in serie, qualche giardino, qualche chiesa. L’aeroporto è affollato, tutti a Bergamo, Orio al Serio.
George e Eugenio restano: e noi li invidiamo un po’, vanno in ricognizione sul delta del Danubio, quello che “il maestro”, Claudio Magris, usa come metafora di una meta anelata e deludente, e che tuttavia lascia intatto il senso del viaggio. George resta a curare il suo progetto, a cui abbiamo dato il nostro piccolo contributo, ma che non vogliamo smettere di sostenere e di sentire anche nostro: stare nella propria terra, starci trovando una vita possibile, starci con un progetto ambizioso, che vuole tenere insieme lo sviluppo e il rispetto, il turismo e l’equilibrio magico dei villaggi rurali, la produttività e la bellezza. Quasi un sogno.
Susanna Ronconi, agosto 2008.