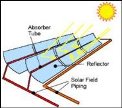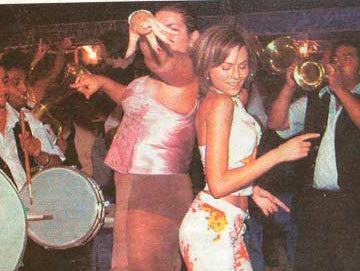di Susanna Ronconi.
Mi pare di essere in Germania, mi pare di essere a casa, dice Cinzia, che parla e insegna tedesco e la Germania la conosce bene. Sibiu-la-bella, e le terre attorno disseminate di chiese sassoni fortificate, hanno architetture mitteleuropee. Così incontriamo il primo dei tanti popoli che hanno attraversato questa terra lasciando segni duraturi. E sono tanti: ungheresi, secleri, rom, tedeschi, turchi, e romeni ovviamente molte città hanno tre nomi: romeno, ungherese e tedesco. Non sono solo le città, anche i paesi sono così, le case rurali mutano da regione a regione, un museo vivente dei passaggi, delle conquiste, delle idee diverse dell’abitare e fare città. Bifore bizantine e gotico tedesco, barocco e fortezze medievali, modernismo sovietico e rococò alla francese, fino a quel mix di orientale e barocco che va sotto il nome di stile brancoveanu.
Lungo il tragitto verso Sibiu incontriamo un museo etnografico all’aperto: sarà l’unico che visiteremo, o quasi, perché è festa nazionale e non è pienamente in funzione. Su questo apro una polemica senza fine, con il gruppo e con me stessa, perché la Romania ha un museo etnografico ad ogni villaggio, fino al grande museo del contadino di Bucarest, e io se vedo una stanza con dentro un rastrello sdentato e una brocca sbrecciata mi ci fiondo passione sbeffeggiata dai più e anche dalle mie amiche. Minoranza. Non faccio adepti. Incasso la sconfitta.
Segno tutto sul mio libretto delle cose incompiute: “fare il giro dei musei etnografici della Romania”, annotazione per il futuro prossimo Questo, è un villaggio nel verde, dove sono ricostruite tutte le architetture rurali delle diverse regioni, le case di legno e di paglia, le stalle, i pozzi a bilanciere, le filande, i mulini, le cappelle. Fin nel più piccolo particolare di questa architettura minore e contadina emerge l’incrocio dei popoli e delle culture e si rinnova la magia della differenza, quel miscuglio di ragioni – fatto di caratteri, economia, natura, incroci meticci, fantasie e sentire profondo – che fa sì che a pochi chilometri un tetto sia di paglia e un altro di tegole di legno, un mulino abbia vele di tela grezza e un altro di legno scuro. La magia della differenza disegnata dal tempo.
Sibiu è viva, piena di giovani, un primo giro serale ce la mostra quasi viennese, nella piazze e nei palazzi, e tedesca nelle torri, e piena di caffè affollati. Ci sono i tetti con gli occhi, piccoli abbaini su tetti spioventi che pare abbiamo palpebre discrete e guardino di sottecchi. Sui comignoli, grandi nidi di cicogne. Ci sono musei, ma alla fine preferiamo un giro in città, strade e piazze, un borgo del seicento, e un caffè discreto sotto il nido di cicogne. Dormiamo da Maria, la prima di queste donne imprenditrici del nuovo tempo, che vorrebbe chiacchierare ma noi fuggiamo via, la sua casa ai margini del centro storico, da fuori non la indovini, solo un portone in una strada di passaggio, dentro stanze su tanti dislivelli, e un piccolo giardino con un gazebo per la colazione del mattino. A fianco, un orto, e una casa diroccata, prato incolto di periferia, da cui spuntano i primi indizi di un ponteggio. Sibiu-la-bella si fa il maquillage.
La terra sassone ha piccoli villaggi rurali, con le strade sterrate, le case basse, alberi carichi di frutti e orti fioriti, i vecchi davanti alle case, al tramonto, il tempo lento, che solo una incursione curiosa della Lonley Planet strappa all’oblio turistico. Ma niente paura, non c’è folla. A Sibiel c’è una chiesa con un piccolo cimitero, potrebbe essere Tirolo, salvo che lì le croci sono in ferro battuto e qui in pietra, ma si respira lo stesso tramonto viola, con le rondini che volano basse e un campanile con la campana, che al vespro suona con voce calda, tirata su e giù da una ragazza che si intravede appesa alla corda saltare a ritmo, i capelli biondi che svolazzano a tempo. Vicino alla chiesa c’è un piccolo museo, il Zosim Panacea, sono le icone di vetro salvate e collezionate da un prete ortodosso e dalla gente di qui, raccolte nei villaggi, nelle case. Sono icone della madonna, e di san giorgio e di una folla di altri santi e angeli, e poi di un cristo paffuto che dà vita alla vite, il ramo della pianta gli esce dal costato e si sviluppa in grappoli gonfi e coloratissimi. Le icone sono vivaci, pagane e poetiche, Chagall forse ha fatto un viaggio qui, perché ci sono buoi e cavalli che volano nel cielo violetto insieme ai santi e agli angeli. E la madonna mostra il seno, e lo porge, nudo, al bambinello. Sulle pareti delle scale, ritratti fotografici color seppia degli uomini importanti del paese, volti dell’ottocento e del novecento, lo sguardo dritto in macchina, serio, la postura impettita eppure poetica: il pope, il sindaco, il maestro.
Qui, le icone si dipingono ancora. Andiamo a trovare una madre e una figlia nella loro casa bassa. Nel piccolo cortile, una coppia prende il fresco della sera: sono israeliani, e vengono sempre in vacanza qui. Le traiettorie degli uomini sono sempre sorprendenti. Dal cortile, due stanze col tetto basso, il laboratorio. Icone di vetro colorate, le foto della madre e della figlia che dipingono, colori, la confusione di ogni atelier. Decido subito, come quando sono gli oggetti a chiamarti: adamo ed eva, l’albero delle mele rosse, un serpentone d’oro avvoltolato su tronco, in cima il dio con la barba nel triangolo e sotto, sulle radici, una madonna col manto rosso che dovrà darsi un gran da fare, nei millenni successivi, a sconfiggere il peccato. Che poi è anche la conoscenza (come la mettiamo?). Loro, l’uomo e la donna sono deliziosi, lei è decisa, è ben quella che osa i seni a pera, il gonnellino di foglie e la mela, ancora nella bocca del serpente tentatore, ma già saldamente nella sua mano. Lui, si tocca con aria interrogativa la barba, si vede che non sa bene cosa fare, incerto e poco incline a osare. Già si sa, come va a finire. Ecco due altre donne, la giovane e la vecchia, sospese tra passato e presente, tra la strada sterrata, il cavallo e il turismo, tra i campi e la Lonley Planet, tra la tradizione e il business. Ma c’è, ancora, qui, quell’equilibrio, il dio col triangolo non ha tolto ancora le sue mani dal villaggio. Le donne ci offrono un bicchiere di grappa e delle frittelle dolci ancora calde. La grappa prima di pranzo e cena e come benvenuto, non importa quale ora sia del giorno o della notte. Dovremo farcene una ragione.
A Sibiel si cena e poi George finalmente tirerà fuori la sua fisarmonica e le due donne inglesi del tavolo accanto dovranno subire le nostre stonature fino al crescendo epico e invitabile di bella ciao, la sola canzone di cui tutti sanno tutte le parole e non si deve fare, a un certo punto, la la la A loro compenso, la bellezza dei pezzi popolari suonati da George. Questo posto si chiama Mioritica, è di Sorian, un omone con i baffi che mette insieme tutte le lingue, guascone che parla a voce alta e scherza, facendo di se stesso un personaggio. Un maschio imprenditore, finalmente. Il luogo è un insieme di luoghi, una casa centrale, tante casette e stanze di legno disseminate tra fiori esuberanti e disordinati, piccoli giardini un po’ selvaggi, un torrente che scorre tra la casa e un piccolo gazebo arrampicato sull’altra sponda. C’è vento e fa buio, cediamo al desiderio di tepore e ceniamo all’interno, in una sala-museo affastellata di arnesi contadini vecchi e nuovi, di pentole di rame, di rastrelli, di macchine per fare il burro (gioisco, una trattoria-museo). In tavola arriva la mitica polenta romena con il formaggio, la mamaliga, e poi lo spezzatino. E il vino. Mangiamo e cantiamo, la stanchezza è in agguato ma stemperata da una dolcezza fatta di calore, di curiosità, di vacanza, di suoni, di nostalgia non si sa bene di cosa. Prima della cena, il baffo ci mostra anche una stanza minuscola, con un letto di legno, qualche scaffale, una piccola finestra: la stanza del passato. Foto e scritti di Ceausescu, la falce e il martello. “Nostalgico?” gli chiediamo, onestamente incuriositi e pensando anche “e perché no? Qualcuno ci sarà pure..” Lui ride più con gli occhi che con la bocca, fa un gesto come a dire “ma vi sembro il tipo?” Ma il fatto è, dice, che non si deve dimenticare il passato. Giusto, baffo, giusto. La smemoratezza crea mostri.
George voleva che pernottassimo qui, avrei fatto a pugni per una notte nella stanzetta del passato, affacciata sulla falce e il martello. Ma la Lonley Planet ha colpito e non c’è posto.
Da Sibiu-la-bella a Sighisoara il paesaggio è dolce, disseminato di paesi rurali definiti dal “lindore sassone”, Cinzia è sempre più a casa sua, e un po’ anch’io, c’è aria di Tirolo, o di Carinzia, architetture a tetti spioventi, fiori sui balconi, operosità contadina, cieli tersi. Restano sparute terrazze con qualche filare di vite, coltivazione pare portata dai sassoni, sviluppata per lungo tempo ma poi quasi abbandonata. Chissà perché, si dice che questa vite facesse buon vino, e non a caso esce ancora oggi dal costato di cristo carica di grappoli, ma oggi trovare una collina di filari è davvero un terno all’otto. I sassoni hanno lasciato anche tracce meno labili, le architetture di pietra delle chiese fortificate, il divino in guerra, la religione che si erge in difensiva dallo spettro dell’orda turca. La chiesa di Biertan ha un grande fascino, minaccioso e autorevole, si erge sopra un paese contadino ordinato in cui vien voglia di sostare, solo si avesse il tempo, per condividerne almeno per qualche giorno il ritmo (nuova annotazione nel libretto delle cose incompiute), alte e doppie mura di cinta, tetti aguzzi di mattone, la chiesa, le torri, su uno sfondo di colline di querce e faggi. Una torre è detta dei divorzi, pare che le coppie sull’orlo della crisi vi venissero chiuse per qualche settimana con la dotazione di un giaciglio matrimoniale e un coltello, e si stava a vedere come sarebbe andata a finire. Pare che i divorzi effettivi fossero pochi. C’è anche un bel ristorante, ma noi ci fermiamo all’aperto, sotto le mura, dove si vende birra e alcuni vecchi sonnecchiano nel caldo pomeridiano davanti a un boccale della mitica Ciuc.
Sfidando la temperatura del pulmino di George, inesorabilmente rimasto al sole, dotati di un carico di bottigliette di acqua gelata, percorriamo in su è giù il verde altalenante della Transilvania fino a Sighisoara. La città ha anche un nome tedesco e uno ungherese, i sassoni ci sono dal dodicesimo secolo e pare che oggi siano tornati in forze, questa volta non con corporazioni e commerci ma con capitali da investire anche per la rigenerazione urbanistica della città, che alterna stradine sterrate e fangose, quando piove, a palazzetti lindi dalle tinte pastello. Sighisoara è la città natale di Vlad Tepes – il Dracula quello vero, l’eroe che tenne a bada l’orda dei turchi, non il personaggio pedofilo e sanguinario della letteratura – ma nel complesso non si viene aggrediti dal mito turistico e dall’invadenza retorica dei souvenir, fatta salva qualche tazzina con un dracula dentato cui per altro anche noi soccombiamo. Ognuno ha a casa un nipote o un amico che se la aspetta. La casa natale sfugge al mito grazie a un prosaico ristorante che vi si è insediato, lasciando sul muro esterno una lapide sobria, sormontata da un geranio rosso fuoco. La città è bella, tedesca e vivace, più tedesca di così non si può: la torre dell’orologio, che guarda sulle colline morbide su cui sorge la città, esibisce un orologio che ad ogni ora mette in azione un grande carillon, si alternano figure e personaggi, che escono dal buio degli ingranaggi verso la luce della piccola piazza. Più tedesca di così non si può: il perimetro è costellato da torri solide, ognuna porta il nome della corporazione che l’ha costruita e che si prendeva cura della difesa di una porzione della città e del suo muro di cinta, ci sono gli orafi e i sarti, gli artigiani dei metalli e quelli del legno. Una lunga scalinata di legno coperta e ombreggiata da una volta porta al cimitero, sassone anch’esso, dove antichissime lapidi di pietra grigia portano stemmi, simboli, piante stilizzate e animali, smangiati e limati dal tempo e messi lì, con una sorta di disordine casuale e struggente. Piove a tratti, nel pomeriggio, le stradine del centro si trasformano rapidamente in rigagnoli, i nostri sandali lasciano i piedi nudi e ci consentono un refrigerio inaspettato. Ci prendiamo del tempo, ci fermiamo un paio d’ore nella piazzetta centrale, chiusa tra palazzetti colorati, ai lunghi tavoli di una birreria. E’ qui che nascono chiacchierate, racconti di sé, Maria Grazia, Renato, Alessandro, si comincia ad attribuire ad ogni volto del gruppo anche una manciata di parole, brandelli di una storia individuale. L’aria profuma di pioggia e di terra.
La sera ci offre qualche risata, in un ristorante pizzeria dove Gabriella decide di correre l’avventura di una ciorba, una zuppa di trippa. Esperimento non del tutto riuscito. Forse anche perché è agosto ed è stato un giorno caldo, o forse perché lei, ardita, decide di proseguire con un semifreddo gigantesco. Ma ciorba a parte, i tavoli si affacciano sulla città e le sue colline, la serata è dolce, il locale è pieno di giovani e ci aspetta un piccolo hotel barocco affacciato sulla torre, con camere ampie dove dormiremo il sonno dei giusti, e balconi pieni di gerani rossi.