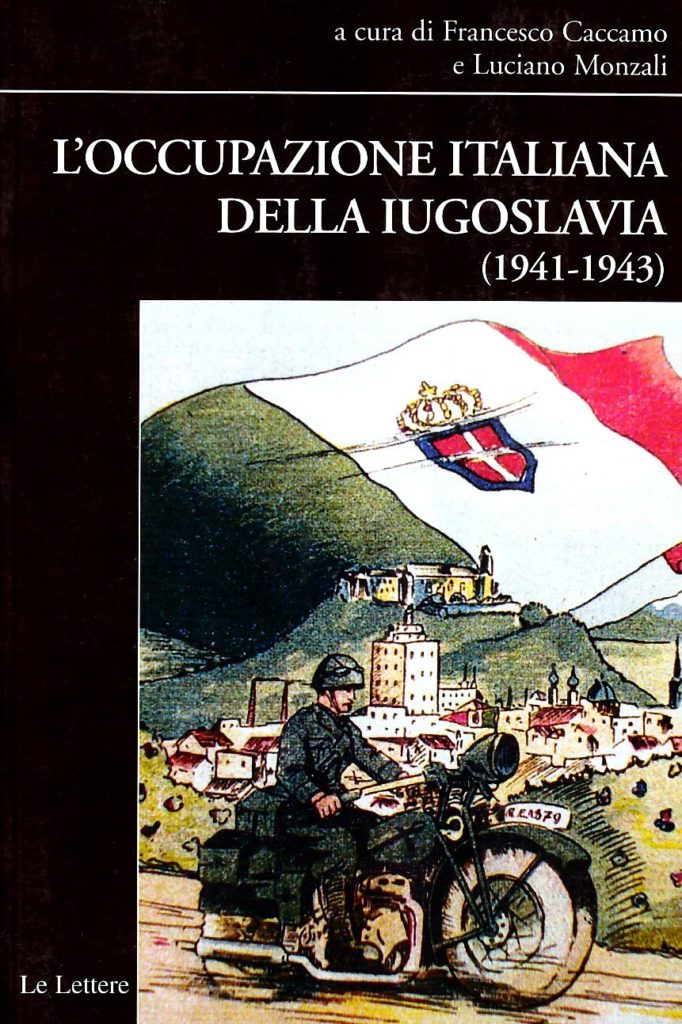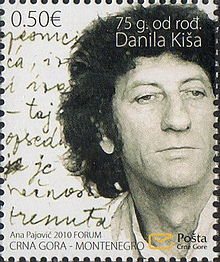Martedì 6 aprile 2021 ricorrono esattamente 80 anni dall’invasione italiana del Regno di Jugoslavia. Un’operazione condotta con le altre forze dell’Asse: in primis la Germania, ma anche Ungheria e Bulgaria. Ciascuno prenderà la sua fetta, sbranando a morsi lo Stato della monarchia Karadjordjević.
Si apre un capitolo che vedrà noi Italiani reprimere con violenza la resistenza partigiana, ma anche la popolazione civile, fino alla caduta del Fascismo e all’Armistizio del 8 settembre. Sono anni di profonde sofferenze per uomini e donne di ogni età in Slovenia, attorno e alle spalle di Fiume, in Dalmazia e Montenegro: uccisioni, villaggi dati alle fiamme, deportazioni in campi di concentramento, molti dei quali creati sul territorio della nostra penisola: Gonàrs e Visco nei pressi di Udine, Monigo a Treviso, Chiesanuova a Padova; ma l’elenco è più lungo. Di tutto questo, come del nostro passato coloniale in Africa, ricordiamo poco o nulla, avendo preferito coltivare negli anni l’immagine del “buon Italiano”.
Se Viaggiare i Balcani coltiva la memoria di questi fatti e di questi luoghi (https://www.viaggiareibalcani.it/proposte/memorie-italiani-brava-gente/), una mostra fotografica realizzata sul web dall’Istituto Parri cerca di strapparci dall’amnesia, facendoci ricordare e riflettere. L’articolo riportato qui sotto, a firma della giornalista Simonetta Fiori e pubblicato sul quotidiano La Repubblica il 2 aprile, spiega in dettaglio quest’iniziativa.

LA JUGOSLAVIA DELL’ORRORE
Quando i criminali di guerra erano gli Italiani
Una mostra fotografica visitabile dal 6 aprile online ricostruisce stragi, violenze, deportazioni ai danni delle popolazioni slave compiute dai soldati di Mussolini tra il 1941 e il 1943. Una storia rimossa che non ha mai visto giudicati i colpevoli.
di SIMONETTA FIORI – La Repubblica, 2 aprile 2021
Gli italiani sono abbastanza maturi per affrontare il buio dei crimini assati? Se lo sono domandati gli organizzatori della grande mostra fotografica che per la prima volta, senza cautele o autocensure, rende pubbliche in modo organico tutte le efferatezze commesse dai soldati di Mussolini tra il 1941 e il 1943 in Jugoslavia. La risposta è nelle numerose immagini che documentano visivamente la nostra ferocia, teste di partigiani slavi infilzate nei pali come trofei, villaggi bruciati, corpi ischeletriti di bambini deportati nei campi italiani. Un museo degli orrori largamente rimosso per ottant’anni, all’ombra di tragedie storiche ancora più grandi come quelle
commesse dai carnefici di Hitler (A ferro e fuoco. L’occupazione italiana della Jugoslavia 1941-‘43, visitabile da martedì 6 aprile sul sito www.occupazioneitalianajugoslavia41-43.it).
Storie di crudeltà che vanno oltre la disumanità della guerra, rimaste fuori dalla coscienza collettiva anche perché mai sanzionate da un tribunale italiano. I responsabili militari non sono mai stati puniti. «Altri paesi come la Germania hanno mostrato più coraggio nel fare i conti con il proprio
passato oscuro. Speriamo che dopo ottant’anni sia venuto il momento giusto», dice Raoul Pupo, lo studioso che ha curato la mostra organizzata dall’Istituto nazionale Parri e dall’Università di Trieste.
I materiali arrivano dalle ricerche compiute in questi anni da storici non solo italiani. Dagli studi di Enzo Collotti a quelli di Davide Rodogno, e poi ancora di Filippo Focardi, Alessandra Kersevan, Carlo Spartaco Capogreco, Costantino Di Sante, Eric Gobetti e Federico Goddi, la bibliografia è piuttosto nutrita. «Ma al di fuori di una ristretta comunità scientifica non s’è mai sedimentata una consapevolezza storica collettiva», aggiunge Pupo. «Per la prima volta presentiamo al grande pubblico i frutti delle ricerche storiografiche. E per la prima volta le istituzioni italiane si assumono
la responsabilità dei crimini commessi in quelle terre occupate. La mostra ha il patrocinio della Camera dei Deputati: un segnale molto importante».
La rassegna digitale coincide con l’ottantesimo anniversario dell’occupazione nazifascista della Jugoslavia. Il 6 aprile del 1941 le truppe naziste diedero inizio a una nuova pagina buia della storia europea, aprendo la strada ai reparti italiani. L’intreccio tra conflitti di natura diversa – guerra di liberazione, guerra civile, guerra etnica – dà origine a un vortice di violenze in cui «le truppe italiane nei territori annessi o occupati – ossia la provincia di Lubiana, il Montenegro, la Dalmazia, parte della Croazia – non furono semplici spettatrici ma protagoniste». Gli ordini repressivi dei generali Roatta e Robotti – da eseguire “senza falsa pietà” – non sono meno efferati di quelli impartiti dai tedeschi nel medesimo teatro di guerra e più tardi in Italia. Nel luglio del 1942 scende in campo lo stesso Mussolini: «Deve cessare il luogo comune che dipinge gli italiani come sentimentali, incapaci di essere duri quanto occorre». E nel 1943 si rivolge
direttamente ai soldati: «So che a casa vostra siete dei buoni padri di famiglia, ma qui voi non sarete mai abbastanza ladri, assassini e stupratori». I militari obbediscono, bruciano i villaggi e sparano ai civili, «anche per dimostrare l’efficienza del proprio reparto», spiega lo storico Brunello Mantelli. Nel luglio del 1942 un soldato toscano affida a una missiva la sua esperienza di guerra: «Abbiamo distrutto tutto da cima fondo, senza risparmiare gli innocenti. Uccidiamo intere famiglie ogni sera, picchiandoli a morte o sparando contro di loro. Se cercano solo di muoversi, tiriamo senza pietà e chi muore muore». Si procede ad arresti, a incendi, a fucilazioni di massa fatte a casaccio. «La frase “gli italiani sono diventati peggiori dei tedeschi” compendia i sentimenti degli sloveni verso di noi», annota il commissario civile del distretto di Longatico nell’estate del 1942. Le fotografie mostrano i corpi di partigiani esibiti come prede, donne anziane condotte senza pietà all’esecuzione, le resistenti chiuse nelle bare. E anche le violenze commesse dal fronte avverso, con i soldati italiani evirati o sgozzati in Montenegro. Seppure vietati dalle autorità militari, abbondano i saccheggi indiscriminati. Nelle lettere a mogli e sorelle i soldati italiani rivendicano ruberie di tappeti, orologi, scarpe da donna, pantaloni alla zuava, scorte alimentari. Nel corso dei rastrellamenti, talvolta si lasciano andare a veri e propri eccidi. L’8 luglio del 1942 un reparto distrugge Podhum, un paese considerato una possibile base d’appoggio per i partigiani nel territorio annesso alla provincia di Fiume. I maschi dai 16 ai 65 anni vengono fucilati (108 persone). Tutti gli altri – donne, vecchi e bambini – sono deportati. Un alpino italiano sopravvissuto, Giovanni Corvino, ricorda la strage di Ustje, scatenata dall’uccisione di un
commilitone: la rappresaglia è raccontata con voce ferma, senza temperatura emotiva. Dopo l’inferno jugoslavo, Corvino ha subito la prigionia in un lager tedesco. La memoria appare raffreddata, come per difendersi dall’orrore.
Le immagini di scheletri viventi ci conducono a un’altra sezione della mostra, dedicata ai campi di internamento nelle isole dalmate e in Italia. Non riuscendo ad avere ragione dei ribelli, le truppe italiane procedono all’evacuazione delle zone ad alta intensità partigiana. Complessivamente
vengono deportate almeno trentacinquemila persone. Quattromila non avrebbero retto alla fame e a condizioni disumane. Il campo peggiore è quello di Arbe, una tendopoli esposta al vento della bora. Le fotografie ci mostrano mucchietti di bambini pelle e ossa che il nostro immaginario confina tra le atrocità del nazismo. A Gonars, in provincia di Udine, cinquecento persone non sopravvivono agli stenti: settanta sono infanti al di sotto di un anno. «Liberaci da questo campo, dal Golgota della nostra vita», scrive una deportata alla famiglia. Una giovane mamma slovena racconta del suo bambino piccolo sistemato per un momento su una pila di stracci e poi inghiottito dall’autoclave: riesce a salvarlo, ma poco dopo il figlioletto muore di fame. Alle proteste della Croce Rossa internazionale per la denutrizione dei prigionieri nel campo di Arbe, il generale Gastone
Gambara risponde: «Logico ed opportuno che campo di concentramento non significhi campo di ingrassamento. Individuo malato = individuo che sta tranquillo».
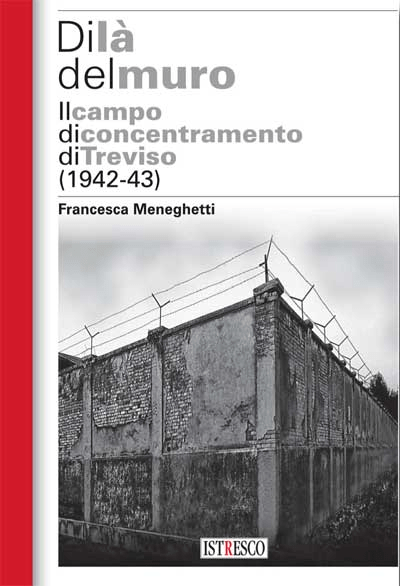
Nessuno dei vertici militari subirà un processo. Nell’ultima parte della mostra, Filippo Focardi ricostruisce meticolosamente la protratta rimozione. Già dall’autunno del 1944 l’Italia provvede a costruire una “contro documentazione” – rispetto alla denuncia da parte jugoslava – e due anni più tardi rivendica il diritto di giudicare i criminali italiani nei propri tribunali. Ma nel 1948, per ragioni di diplomazia internazionale, nessuno ha più interesse ad andare a fondo. E nel 1951 vengono chiuse le inchieste. Oltre mezzo secolo più tardi, il procuratore militare Antonino Intelisano apre un’inchiesta contro ignoti, per poi chiuderla per mancanza di imputati: i responsabili di quei crimini sono tutti morti. Le vittime jugoslave restano senza giustizia.
Alla fine della mostra – dopo dieci sezioni, cinquanta pannelli, duecento immagini, venticinque testimonianze d’epoca – il mito degli “Italiani brava gente” appare in frantumi. «A pochi piace fare la parte del malvagio, specie se questo incrina una delle leggende su cui si fonda un’identità collettiva», conclude Pupo. «Ma se un’identità è matura, non ha paura del buio».